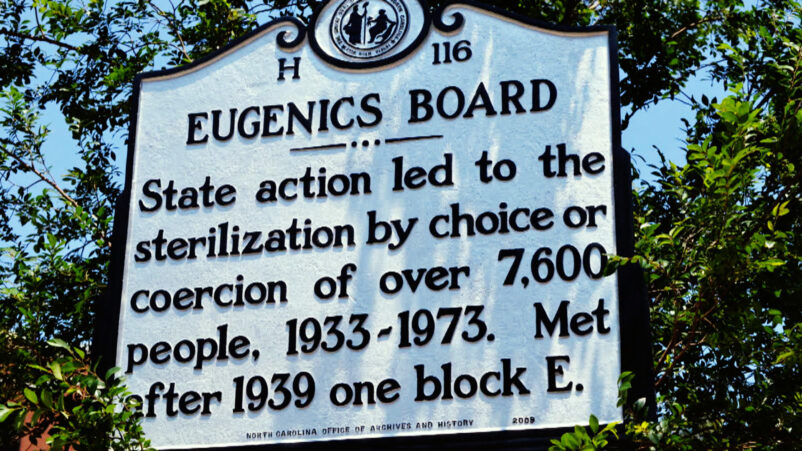Gladden Pappin, professore all’Università di Dallas e cofondatore della prestigiosa rivista American Affairs, intervistato da Il Giornale del 12 novembre scorso ha spiegato le trasformazioni intervenute nel mondo politico americano con l’avvento sulla scena di Donald Trump. A suo giudizio il trumpismo ha modificato l’Old Party, ossia il partito repubblicano, in una forza a tendenza populista e sovranista con forti attenzioni al sociale nell’ottica di una politica economica protezionista e quindi antiglobalista.
Il “Partito Repubblicano è diventa(to)”, ha affermato Pappin, “la voce di un conservatorismo sociale, delle varie etnie, della classe operaia rimasta, contro le pressioni dei media, al fianco di Trump negli ultimi quattro anni. Diversi senatori repubblicani, soprattutto Marco Rubio (Florida) e Josh Hawley (Missouri), nonché personalità televisive come Tucker Carlson di Fox News, hanno abbracciato la nuova direzione del conservatorismo sociale. Una visione conservatrice di successo dovrebbe garantire il bene comune con una forte politica industriale e per le famiglie”.
Il sito gliStatiGenerali ha pubblicato l’8 novembre scorso uno studio, a firma di Paolo Natale, sulle scelte dell’elettorato statunitense. Da questa indagine è venuto fuori che mentre le città e l’alta borghesia colta, quella cosmopolita e liberal, hanno votato per Biden, le periferie, le zone rurali, quindi il ceto più povero e la piccola e media borghesia, hanno votato per Trump. Lo scenario così delineatosi è quello di un’America divisa nello scontro tra l’élite radical-chic e la popolazione più esposta alla destabilizzazione sociale causata dalla globalizzazione.
Non si tratta, dunque, soltanto dell’“ignoranza” del popolo meno istruito, come scrivono i commentatori di sinistra allineati alla narrazione mainstream. Infatti, Federico Rampini, inviato negli Stati Uniti per Repubblica, uno degli opinionisti di sinistra più onesti ed intelligenti ma fuori dal coro, profondo conoscitore della società americana e delle sue dinamiche, autore di un libro La notte delle sinistra che ha demolito i miti globalisti ed “arcobaleno” dei liberal americani ed europei dimostrando ad essi la deriva verso la quale naviga una sinistra strumentalizzata dal grande capitale finanziario transnazionale, ha criticato, in una recente puntata del talk show televisivo “Piazza Pulita”, sul canale La7, l’atteggiamento di chi, nei riguardi dell’elettorato di Trump, parla di “volgare plebe sanfedista”. Rampini ha fatto osservare che Joe Biden è un neoliberista il quale sia con Clinton sia con Obama ha appoggiato le peggiori politiche liberoscambiste, che hanno prodotto le delocalizzazioni industriali e l’impoverimento dei ceti popolari, sicché se ora il voto dei ceti più deboli è diretto in America a Trump ed in Europa a sovranisti come la Le Pen o la Meloni è perché essi, contestando, in nome delle identità nazionali, la globalizzazione, difendono anche gli interessi popolari contrari a quelli del capitalismo apolide.
C’è del vero in questo genere di analisi. Il trumpismo non è il reaganismo né il bushismo. Trump ha fatto appello ai ceti indeboliti dalla globalizzazione, alla middle class defraudata del “sogno americano”, ossia del posto sicuro e della villetta con entrata separata e garage, ma anche alla working class destabilizzata dalle delocalizzazioni industriali e dalla finanziarizzazione dell’economia intervenuta nel trentennio dei Clinton, dei Bush e degli Obama. Un trentennio del quale un film di qualche anno fa – che raccontava la storia di un quadro intermedio di una azienda americana costretto per non perdere il lavoro a tentare di vendere oggetti quasi fuori mercato trascinandosi dietro il figlioletto e dormendo nei dormitori pubblici avendo perso la casa – rappresentò lo spaccato. Indubbiamente la globalizzazione – quasi offrendo una postuma rivincita a Karl Marx – ha distrutto il ceto medio ed ha aumentato la forbice tra ricchi e poveri anche in Occidente e non solo quella tra primo e terzo mondo.
Il trascorso successo di Trump e la sua rimonta elettorale, che ha dimostrato come il populismo trumpiano non è affatto morto – infatti non c’è stata l’ondata blu pronosticata dai sondaggisti e dai media –, hanno acceso l’entusiasmo dei sovranisti nostrani che interpretano il trumpismo alla stregua di qualcosa di simile a ciò che da noi si chiamerebbe “destra sociale”. Una esegesi, però, in parte erronea, soprattutto nei riguardi della politica estera praticata da Trump, perché l’analogia tra il trumpismo ed il sovranismo sociale, in certi casi come in quello del francese Melenchon addirittura socialista, è molto vaga dato che il fenomeno Trump, pur provenendo da una antica radice populista presente sin dal XIX secolo nella cultura politica statunitense e della quale fu in qualche modo espressione anche il grande Ezra Pound, non ha alle sue spalle la stessa storia politica, così fortemente intrisa di socialismo a-marxista, degli ascendenti “fascisti” del nostro sovranismo.
Di sicuro, la politica estera mediorientale di Trump – ma sarebbe meglio dire di sua figlia Ivanka e soprattutto di suo genero Jared Kushner, vicino alla destra religiosa evangelica americana ed a quella fondamentalista ebraica nonché lui stesso di origini ebraiche – è del tutto lontana dal milieu culturale nel quale affonda, o dovrebbe affondare, il sovranismo italiano ed europeo ed è assolutamente contraria ai nostri interessi geopolitici quali italiani ed europei mediterranei. Un aspetto della questione che tuttavia non viene quasi mai preso in considerazione dal nostro sovranismo al quale piace cercare sponde oltreatlantico invece che guardare alle sponde, per storia nazionale e cultura politica più confacenti, della Russia e dei Paesi che nel vicino oriente non accettano l’egemonia atomica di Tel Aviv. Il riconoscimento trumpiano di Gerusalemme quale esclusiva capitale dello Stato di Israele è stato uno schiaffo in faccia non solo all’islam, sunnita quanto sciita, ma anche a milioni di cristiani, di tutte le confessioni, senza che nessuno tra i nostri sovranisti, in particolare tra quelli catto-sovranisti, abbia avuto alcunché da ridire.
L’unico aspetto della politica estera di Trump, e non lo diciamo per incensarlo, sovranisticamente ed europeisticamente interessante era piuttosto la sua tendenza verso l’isolazionismo. Una tendenza storicamente tipica dei repubblicani laddove i democratici sono sempre stati, al contrario, molto imperialisti ed interventisti. Se l’Europa fosse stata qualcosa di più di un coacervo di interessi bancari avrebbe dovuto caldeggiare la sua rielezione nella prospettiva, però, dell’indipendenza degli Stati europei dalla Nato, che Trump ha dato mostra di porre in secondo piano, e del rafforzamento di una realtà europea di natura primariamente politica. Purtroppo l’UE è solo aria fritta. L’unica preoccupazione della Germania, ossia della nazione leader nell’UE, durante la presidenza Trump è stata quella di contrastare la politica daziaria americana che metteva in crisi un’economia, quella tedesca, costruita intorno ad un aggressivo mercantilismo volto alle esportazioni.
Ma se quelle sopra esaminate sono state le ragioni del successo politico di Trump, chi ora applaude alla sua sconfitta elettorale credendo che siamo agli inizi di un New Deal, di un nuovo corso, tutto dedito alla costruzione di un mondo multiculturale, pacificato nella giustizia sociale ed internazionale, attento verso i poveri e gli ultimi, che abbia cura del clima e della terra, è soltanto un illuso che ha abboccato alla canonizzazione mediatica, su scala globale, che è stata fatta della coppia Joe Biden-Kamala Harris.
I commentatori, gli opinionisti, la gente in piazza festeggiante la vittoria (che tuttavia non è stata ancora ufficialmente acclarata) di Biden hanno dimenticato chi è veramente Joe Biden. Qualcuno tra i guastafeste ha scritto che chi ha festeggiato la vittoria di Biden, credendo al successo di un difensore dei deboli, è come quel marito cornuto che ringrazia l’amante della moglie. Tuttavia la pressione mediatica è talmente forte che persino Papa Francesco, non mostrando alcuno scrupolo nei riguardi del dichiarato filo-abortismo del candidato che ha vinto le elezioni statunitensi, sembra aver dato per scontato un Biden tutto per i poveri e gli ultimi della terra.
Orbene, il Biden reale è molto diverso da quello ideale. La sua campagna elettorale è stata finanziata dalle maggiori multinazionali mondiali perché la politica protezionista di Trump contrastava con i loro interessi globali. I poveri, ossia i ceti deboli impoveriti dalla globalizzazione, non hanno votato Biden. Le sue linee di politica estera, inoltre, prevedono un rafforzamento del globalismo a trazione americana senza escludere guerre umanitarie contro i violatori del Nuovo Ordine Mondiale Capitalistico.
Sotto questo profilo, ed in linea con il tradizionale espansionismo democratico in politica estera, Biden rappresenta il volto interventista e “missionario” dello spirito puritano degli Stati Uniti. Questi sono nati all’insegna del puritanesimo per il quale l’America era la terra promessa del nuovo popolo eletto, l’unica terra di purezza incontaminata in un mondo sotto il dominio del diavolo (“papista” o “falso protestante”). Una purezza che doveva essere preservata dagli influssi esterni. Da qui l’isolazionismo dei conservatori americani. Ma nella teologia politica puritana esiste anche un rovescio della medaglia. Se l’America era la terra incontaminata della giustizia essa aveva l’obbligo missionario di purificare il resto del mondo esportando il suo primato. Qui è il nocciolo duro della “dottrina Monroe” e dell’interventismo democratico.
Il banditore forse più noto dello spirito missionario statunitense è stato Thomas Jefferson, terzo presidente democratico degli Stati Uniti dal 1801 al 1809. Egli vinse le elezioni con il partito democratico-repubblicano, come si chiamava all’epoca, contro i federalisti di Adams. Jefferson era solito riferirsi ai neonati Stati Uniti come l’Empire of Liberty. Può a ragione ritenersi tra i padri nobili del cosiddetto “internazionalismo liberale” per il quale gli Stati Uniti hanno il diritto-dovere di espandere il loro sistema sociale ed il loro modello politico nel resto del mondo. Nel pensiero jeffersoniano, il sistema americano in quanto benedetto da Dio è superiore a tutti gli altri.
Da Jefferson in poi la politica americana, salvo alcune fasi di ritorno all’isolazionismo, ha sempre seguito la dottrina dell’internazionalismo liberale nutrita dalla concezione messianica degli Stati Uniti quale, appunto, impero della libertà in lotta senza quartiere contro le forze del male. Tutti gli interventi politici e militari americani sono stati giustificati da tale spirito missionario, anche quando le iniziali motivazioni religiose vennero meno secolarizzandosi. A pagarne le conseguenze fu per prima l’America Latina, il “giardino di casa degli Stati Uniti”, e poi il resto del mondo. Da Woodrow Wilson, che propagandava l’intervento statunitense nella prima guerra mondiale come la crociata della libertà contro i residui medioevali in Europa, a Ronald Reagan che chiamava l’Unione Sovietica impero del male, fino alle guerre umanitarie per esportare la democrazia di G.W. Bush agli inizi di questo millennio, la politica estera americana ha sempre espresso l’originario spirito conquistatore e missionario ispirato dai Padri fondatori.
Joe Biden appartiene in pieno a questa storia ed a questa cultura, benché sia cattolico, ma progressista, e non protestante. Tutti gli atti della sua lunga carriera politica stanno lì a dimostrarlo. Durante la presidenza Obama, del quale era vicepresidente, ebbe un ruolo fondamentale nelle guerre intraprese dagli Stati Uniti. Ma decisivo fu il suo ruolo anche nell’era Clinton. Fu lui a convincere Clinton, inizialmente più prudente, ad intervenire nello scenario iugoslavo, come ha ricordato il sito Eurasia Review che lo ha definito “uno dei principali architetti della guerra di Bosnia dell’amministrazione Clinton negli anni ’90”. Nell’era di George W. Bush, pur essendo fuori dal governo, il senatore Biden fu un fervente sostenitore della guerra al terrore per l’abbattimento del regime di Saddam Hussein contribuendo anche a dare credito pubblico alle fake news sulle “armi di distruzione di massa” possedute dall’Iraq.
Quale vicepresidente di Obama, Biden ha seguito da vicino la politica estera statunitense concorrendo con Hilary Clinton a rafforzare l’egemonia mondiale americana attraverso le cosiddette “rivoluzioni colorate”, finanziate e foraggiate dal governo americano dal 2008 al 2016. Il risultato di tale politica lo abbiamo sotto i nostri occhi, a partire dalle conseguenze nefaste delle “primavere arabe”, che hanno sconvolto il Medio Oriente ed il Nord Africa, fino all’appoggio al terrorismo salafita in Siria per rovesciare Bashar al Assad aprendo uno spazio per l’Isis creatura dell’alleato saudita. Per non parlare, poi, della rivoluzione ucraina di piazza Maidan, della nuova guerra fredda con la Russia di Putin, della prosecuzione delle guerre occidentaliste in Yemen, Pakistan e Afghanistan o della guerra commerciale dei gasdotti per far naufragare il progetto del South Stream.
Biden, però, è un ottantenne che governerà in diarchia con Kamala Harris, sua prossima vicepresidente, nominata a tale incarico per accontentare l’estrema sinistra dei democratici e che il mediasystem globale ha già beatificato. La nuova “santa”, tale non perché vergine né perché martire ma addirittura – udite, udite! – perché “prima donna a diventare vicepresidente degli Stati Uniti”, sarà in effetti, vista l’età avanzata di Biden, il vero occulto presidente del nuovo corso democratico.
Il sito Geopolitical News ha fornito una summa delle idee alquanto belliciste della Harris che come la Clinton, e più di lei, interpreta il ruolo politico degli Stati Uniti nel mondo nei termini della crociata del bene contro il male. Veniamo così a sapere che le idee di politica estera della Harris, condivise da Biden, prevedono i seguenti scenari:
– rafforzamento del contenimento della Russia, dato che quello impostato da Trump viene ritenuto dalla Kamala troppo morbido;
– contenimento dell’espansionismo economico della Cina mediante azioni diverse dalla guerra commerciale di Trump, dannosa per l’economia americana, ma volte allo stesso scopo di riduzione delle pretese di Pechino;
– linea dura con la Corea del Nord, ponendo fine ai tentativi di Trump per un dialogo con Kim Jong Un;
– linea dura con il Venezuela per il cambio di regime detronizzando Nicolas Maduro, anche intervenendo direttamente dato che la politica delle sanzioni di Trump non si è dimostrata efficace;
– potenziamento dell’Alleanza Atlantica proseguendo nella linea di spostamento della cortina di ferro da Berlino a Varsavia;
– prosecuzione dell’agenda per Israele di Donald Trump;
– non esclusione del ricorso, se necessario, a bombardamenti preventivi contro le strutture nucleari tanto di Teheran che di Pyongyang, benché Biden sembra voglia riannodare le fila dell’accordo sul nucleare dal quale si ritirò Trump;
– abbattimento definitivo del regime di Assad in Siria anche per porre rimedio alla politica di Trump che ha permesso alla Russia ed all’Iran di invertire le sorti del conflitto;
– pressione sulla Turchia per un cambio di schieramento;
– rafforzamento del tradizionale sodalizio tra Partito Democratico e certe organizzazioni islamiche come quella dei Fratelli mussulmani, che non a caso hanno già fatto gli auguri a Biden, per utilizzarle come arma di pressione in Medioriente contro i governi scomodi.
Insomma, dopo i festeggiamenti per l’elezione di Joe Biden, aspettiamo nel prossimo futuro i botti. E non saranno certo quelli dei fuochi d’artificio.